Blackstar: Bowie trasforma la propria morte in un'opera d'arte
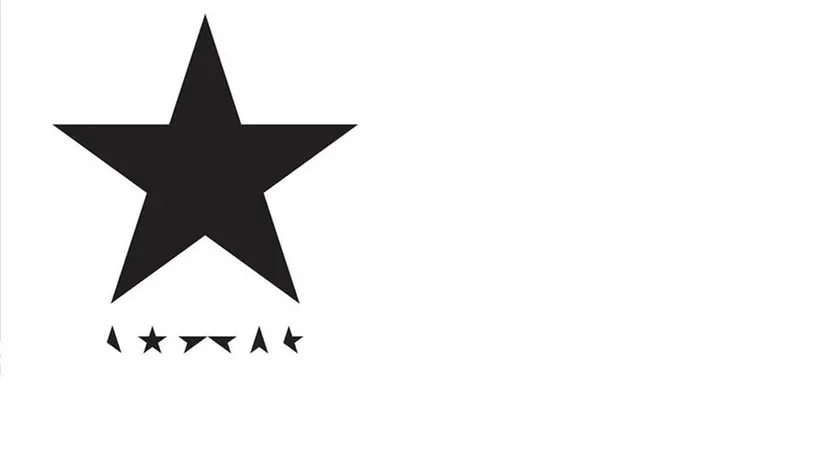
L’uomo che cadde sulla Terra decise di andarsene lavorando alla messa in scena della propria morte per preparare quella vera. Per essere, fino all’ultimo, regista e interprete del proprio personaggio. David Bowie aveva già messo tutto lì, bastava solo raccogliere gli indizi contenuti in «Blackstar», il suo ventisettesimo album, per capire che l’ultimo saluto era iniziato.
Il 19 novembre 2015 esce il primo singolo, intitolato come il disco, ed è una folgorazione. Dieci minuti ipnotici e tenebrosi, tra jazz e elettronica, con una cantilena in cui si narra della villa di Ormen, dove c’è una candela solitaria. È una suite che si apre verso una dolcezza imprevista, è una veglia che porta all’oscurità. E nel video, diretto da Johan Renck, Bowie si copre il volto con una benda che ha due bottoni scuri applicati in corrispondenza degli occhi, che stanno per chiudersi per sempre.
È la stessa benda che ritroviamo, un mese e mezzo dopo, nel video del secondo singolo «Lazarus», uscito l’8 gennaio, giorno del sessantanovesimo compleanno di Bowie, in concomitanza con l’intero album. Ma mentre critica e pubblico celebrano il ritorno in grande stile del Duca Bianco, lui sta portando a termine la trasformazione nella Stella Nera la cui luce è per sempre persa nell’universo.
«Guardate quassù, sono in Paradiso, ho cicatrici che non possono essere viste», canta Bowie. Nel video è a letto, sembra sollevarsi in volo, mentre un alter ego vestito di nero balla in maniera meccanica e scrive spinto da un’ultima forza interiore. Poi, nel finale, arretra tremando e si rinchiude in un armadio.
Poteva essere più esplicito?

«Lazarus», che è anche il titolo di un’opera scritta da Bowie e messa in scena in questi giorni a Broadway, non risorgerà. O forse, come recita il protagonista del musical, l’attore Michael C. Hall («Chicago», la serie tv «Dexter») è «l’uomo che muore ogni giorno, ma non riesce mai a morire».
Tra l’uscita di «Blackstar» e l’annuncio della scomparsa del suo autore sono passati solo tre giorni. Il tempo minimo per apprezzarne le sette canzoni coprodotte da Tony Visconti, trovare echi di Station to Station (1976) e Outside (1995), sentirsi trascinati dal sax di Donny McCaslin («Tis A Pity She Was A Whore»), da ritmiche sincopate («Sue»), da melodie inquiete («Girl Loves Me»), dal mistero della fine («I Can’t Give Everything Away», non posso svelare tutto). E cogliere il contrasto tra l’atmosfera pacificata di «Dollar Days» e il testo, dove Bowie racconta che «tutto è andato male, ma la fine prosegue senza sosta e non finisce mai, sto cadendo». È un disco da inserire, per intensità e ispirazione, tra i capitoli più alti della produzione di Bowie, l’alieno. Che ha trasformato la morte in un atto creativo nell’ultima delle sue reincarnazioni: Ziggy Stardust, Thin White Duke, ora Blackstar.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato